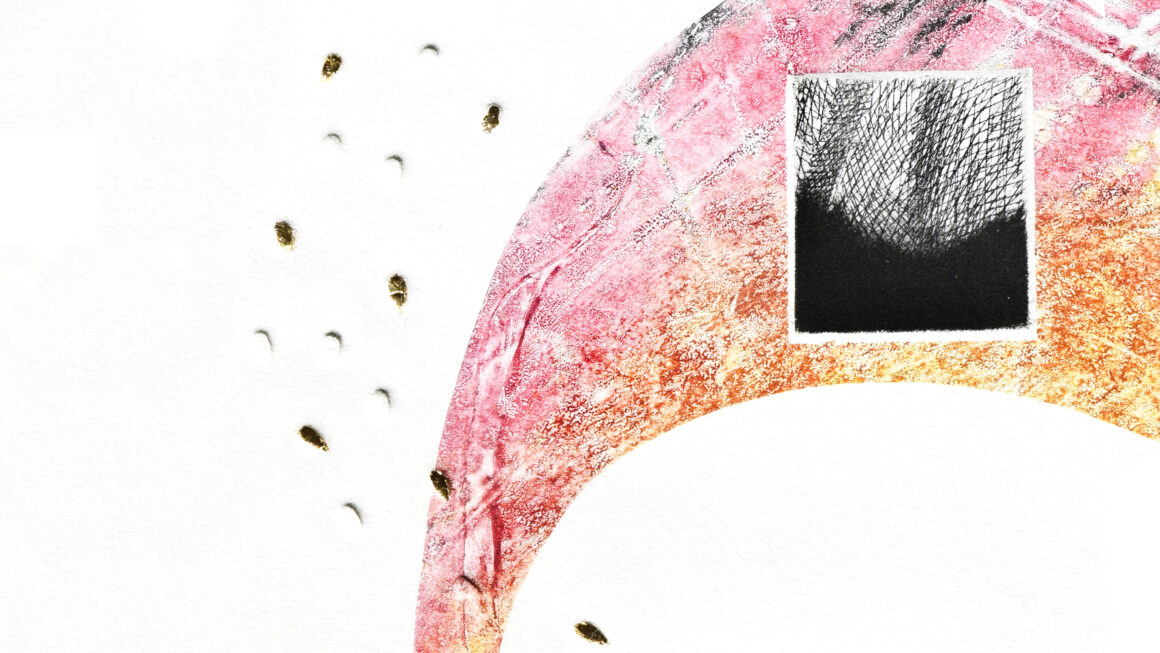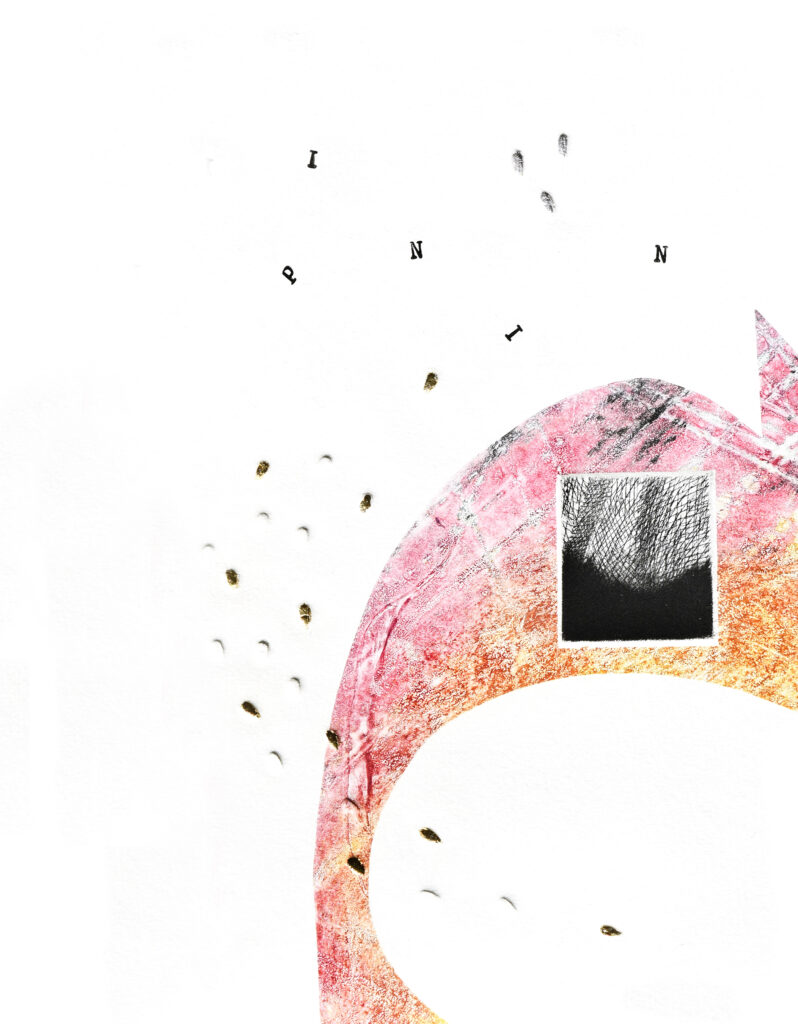Pinin si avviava verso la casa del fratello. Attorno, la strada brianzola avvolta nella bruma di ottobre era fosca e fredda, ma gli appariva amica. I fili d’erba nei campi e le pannocchie se ne stavano ritti e tutti umidi e lo guardavano passare sfregandosi l’un l’altro all’incedere pacato del vento. La sera accoglieva il giovane uomo e lui l’accoglieva vicendevolmente. Alle sue spalle, altrettanto calmo e mesto, il giorno se ne andava, quello si girava e gli faceva un cenno di saluto, com’era solito fare. Pinin viveva tutt’uno con la natura. Fin da bambino aveva amato profondamente passeggiare nei boschi e guardare i fiori, i covoni di grano, usmare il penetrante odore del letame che ammassavano e spantegavano i vecchi tra gli orti. Con gli elementi del selvaggio circostante coltivava un rapporto quasi di simbiosi e se ne stava per ore tra i prati come fosse tra amici e instaurando dei dialoghi con i tronchi delle betulle e le pietre dei muriccioli messi su a secco.
Se da una parte assaporava una forte corrispondenza con gli aspetti naturali del mondo, dall’altra invece non amava interagire con le persone. Gli pareva proprio di non aver nulla da dirgli. Quelli si trovavano, cicalavano e parlottavano per minuti e minuti, scambiandosi sorrisi, presunte gentilezze, pareri, idee, considerazioni sul tempo e così via. Oltre a non interessarlo minimamente, quelle conversazioni – che qualcuno direbbe mondane – gli sembrava nascondessero intimamente delle bugie, degli artifici particolari e sinistri. Guardando muoversi quelle bocche, quegli sguardi e quegli arti gli veniva restituita l’impressione che ci fossero davanti a lui dei corpi vuoti con gli occhi sbarrati e che degli spiriti maligni fatti di niente li osservassero e gli suggerissero cosa dire, alzandogli un braccio, piegandogli in su o in giù gli angoli delle labbra secche.
Non che la cosa lo intimidisse più di tanto, era più stupito per il fatto d’essere l’unico ad accorgersene. Era capitato più d’una volta che lo fermassero per chiacchierare, allorché immediatamente Pinin si estraniava, guardava per aria o fisso negli occhi il suo interlocutore, cercando traccia delle sue vere intenzioni, non quelle dettate dallo spirito eccelso delle buone maniere e del perdere tempo.
Fino a che era stato ragazzo la gente si era rivolta a lui con fare gentile e sguardi indulgenti: «Alura, Pinin, in du è che ta vet?», «Brau Pinin! Te set un brau fioeu!» oppure «Ven scià, Pinin, varda cume l’è bela la vaca» e cose di questo tenore. Col tempo però la sua posa, che appariva sempre distratta e mai pienamente presente al discorso, aveva stancato i paesani che, lasciata da parte la benevolenza che si serba ai bambini, avevano iniziato a prenderlo in giro e trattarlo per quello che era, secondo loro: un martul! E si può anche capirli. Spesso e volentieri, mentre provavano a scambiarci una parola lui si assentava, poi a un certo punto li scrutava e con lievità gli domandava: «Ma scüsum, ma perché ta disat inscì? Cuss’è che ‘l vör dì?!». A quelli pareva non capisse niente.
Tra una cosa e l’altra Pinin si trovò a doversi cercare un lavoro. Si capisce che lì al paese nessuno se lo voleva prendere in casa, che fosse come apprendista, come lustrascarpe o cos’altro. Pensavano fosse troppo, troppo tonto per avere una qualsivoglia occupazione, che si sarebbe dimenticato che stava mungendo una vacca e le avrebbe staccato le mammelle o che segando un tavolo avrebbe finito per segar via anche qualche pezzo di muro – cose così.
Passando il tempo si ritrovò indigente, i suoi non avevano la pazienza di stargli dietro e pure loro, a dirla tutta, non l’avevano mai sopportato. E lo stesso valeva per suo fratello, che faceva Sdraèla di nome, fatto d’una pasta tutta diversa da Pinin. Era forzuto, sveglio, abile negli affari e nella chiacchiera e dotato d’un occhio vispo; insomma, un tipo “sul pezzo”. A rinforzarne la fisionomia di grand’uomo gli erano stati concessi una bellissima e potente voce da tenore, la passione per la lettura (pure intellettuale era) e un vispo appetito sessuale. Lo specifichiamo perché anche questa era una bella differenza tra i due fratelli: Pinin infatti, del sesso non se n’era mai preoccupato e anzi, quando qualche ragazzetta aveva tentato un approccio lui l’aveva mandata al diavolo o s’era messo a far ciondolare la testa, ammutolendosi per delle buone mezz’ore.
L’unico nell’intero paese che gli aveva dato retta era stato il vecchio Pietro, detto Pedar “dal vigna” per il fatto che teneva sempre a braccio un fiasco di vino nero, che bello bello sorseggiava lungo l’arco della giornata.
Pedar gestiva un teatro di burattini ambulante che portava in giro per mezza Brianza. Era tanto amato dai ragazzini, meno dagli adulti sebbene i suoi spettacoli celassero, dietro le farse burlesche, significati nient’affatto scontati: situazioni mondane che rivelavano atteggiamenti ipocriti, battute sottili che sbugiardavano i sovrani, preghiere lontane dall’ortodossia che imbarazzavano i parroci. Per cominciare mise Pinin a staccare i biglietti, a raccogliere gli sghei (come li chiamava lui), mentre si provava ad insegnargli il mestiere. Questo finché un giorno non lo vide per caso fare delle piroette nel prato ed elargirsi in profondi ed eleganti inchini, come se stesse esibendosi per i cespugli in fiore. Da quel momento decise di provare a fargli fare, tra uno spettacolo e l’altro, dei numeri da pagliaccio, cosa che quello accettò di buon grado. Le sue goffe giravolte e le ridicole pose che assumeva riscossero immediato successo. Gli affari per il vecchio Pietro fiorirono e lo strambo Pinin ebbe di che vivere.
Le cose, insomma, parevano andargli piuttosto bene, e tuttavia da un po’ di tempo c’era un qualcosa che non lo lasciava sereno e che costantemente, un pochino, giorno dopo giorno limava severamente il suo umore. Si sentiva solo e soprattutto provava spesso una vaga irrequietudine, come se si sentisse osservato. Alle volte, mentre la sera girovagava, gli sembrava di avvertire strane vocine rauche bisbigliare in lontananza. Per di più non aveva scambi con nessuno: Pedar era sempre ubriaco e più che ridere non faceva, Sdraèla non lo veniva mai a trovare e tanto meno lo calcolavano le altre persone; con chi confidarsi? Dal canto loro persino le piante non si mostravano più responsive come un tempo. In buona sostanza non era felice, e se ne rendeva conto.
Quella sera aveva deciso di andare a trovare il fratello, che viveva un po’ fuori dal centro in un casolare che prendeva un bel sole la mattina e una fresca ombra la sera, insieme ad un venticello leggero. Sperava di poterci parlare, che Sdraèla gli mostrasse un po’ d’affetto e magari gli offrisse un poco di polenta fumante, con del formaggio – perché no? Itinerante col teatro, stava spesso digiuno o si accontentava di patate, qualche salsiccia e poco altro. Una bella polenta calda gli mancava. Da lontano un profumino di stufa accesa e di farina gli fece accelerare il passo. Il casolare era là a fondo della via e si vedeva dal comignolo uscire del fumo, segno che qualcosa si stava cucinando. Un languorino prese lo stomaco di Pinin, insieme alla speranza di un’accoglienza calorosa da parte del fratello e di sua moglie.
Dalla finestrella Sdraèla e sua moglie lo videro in cima al sentiero avviarsi verso la loro casa. «Oh Sdraèla, va che ‘l rüa quel martulott del tò fredel». «Da bon? Fa’ na roba, sara sü tusscòss, e smorza ul föc». Appena entrato, Pinin si trovò davanti i due seduti al tavolo, che gli sorridevano. Subito notò un forte distacco tra le loro parole e quello che gli comunicavano gli occhi.
«Buonasira Pinin, qual buon vento, cume mai te sé scià, ta set in giir a fa cuss’è? Vegn, vegn, setas gio che». Di fianco l’Angelina stava in piedi tutta tirata, osservando ed elargendo qualche sorriso trattenuto: «Che bella sorpresa, caro Pinin!». «Uè Sdraéla! Alura, cume nemm? Mah, nagot, sevi giamò in giir e u pensà: cià che passi là a salüdal – dopo un attimo proseguì – e a saludà anca la sciura» e sorrise ad Angelina. Sdraéla si tirò in piedi e gli si avvicinò. «Varda, sun propri cuntent, da bon». Poi si impostò tutto e assunse un’espressione contrita e cretina: «Sevum propri drè a dì che l’è sira e che gh’emm famm e che però ‘l gh’è nagot de mangià, veru Lineta?» e quella assentì secondo copione. «A mi ma saria piasü de dat un quiscòss, un tuchelin da pulenta o un fiten da furmacc per sta chi tücc insema, ma ta vedat, sem dü puaret… e pö adess l’è anca ura del rusari, par ul vespar, podum mia sta che a parlà, l’è mej nà in gesa. Sa preparum Lineta?».
I due cominciarono a vestirsi allora, presero su i cappotti, entrambi belli, puliti e caldi e calzarono le scarpe, altrettanto pulite ed eleganti. Diversi quadri campeggiavano appesi ai muri, il prezioso mobilio precisamente spolverato da un domestico offriva il contorno al quadretto di quella stanza che sembrava tutto fuorché povera, coi pomelli delle porte in madreperla, il lampadario finemente elaborato e le sedie scure intarsiate dalla mano di Alfredo, il falegname. In tutto il teatrino, che non comprendeva, ma vedeva nitidamente, Pinin stava immobile, conservando, come ormai aveva imparato a fare, un’espressione gioviale.
Era pronto ad andarsene, ma sebbene non nutrisse più fiducia, gli restava in fondo all’animo la speranza irrealistica che suo fratello stesse parlando sul serio, che veramente non avesse nulla da offrire e stesse uscendo per andare alla messa del vespro – perché no? La ricchezza che trasudava limpida dall’arredo della casetta, il fatto che l’ora gli paresse oramai tarda per recarsi in chiesa – come facevano a fare in tempo? – e i sacchi che vedeva spuntare da una cassapanca (che erano evidentemente quelli pieni zeppi della farina che vendeva il mugnaio) suggerivano il contrario, ma a lui pareva non costasse nulla provare a credere.
«E quindi caro Pinin, passa scià un’oltra volta, se ta set in giir. E magari st’oltra volta sa setum gio a mangià. Tegn, ta lassi un tuchel da pulenta fregia ch’emm fa l’oltrier» e gli mise in mano un cartoccio con un minuscolo pezzetto di polenta, secca e fredda. Dunque uscirono tutti e tre, Sdraéla e Angelina si chiusero la porta alle spalle e poi il cancello. Fatto un pezzo di strada assieme presero poi direzioni opposte, la coppia verso il paese e Pinin verso la campagna.
Dopo qualche passo, girata che ebbe la prima curva, sicuro che non lo potessero più vedere, Pinin si nascose tra gli sterpi e tornò indietro, chino per non esser visto. Vide i due guardarsi attorno controllando che non ci fossero persone in vista e poi riavviarsi per il casolare. Seguitò a pedinarli. A quel punto non aveva più la speranza di aver frainteso, eppure una specie di sensazione, una particolare volontà masochistica che per lui era nuova lo spinse fino alla soglia della casa. Spiò da una finestra laterale: risate fragorose, occhiate maligne d’intesa, le braci che tornavano a fumare. Comparirono un tegame col burro, un paiolo con acqua e farina e un tagliere con della luganiga; e poi un bacio che a Pinin sembrò non suggellasse l’amore, ma la cattiveria.
Pinin non si tenne e sbottò: «Vi olter sii trop catiff! Catiff! Sii diaul! E che l’diaul ve ciapi!». Angelina sentì qualcosa e con un’occhiata intravide appena fuori dalla finestrella sopra il paiolo una sagoma che si agitava. Uscì per vedere chi fosse, ma la sagoma oramai nel buio della sera profonda scompariva tra i cespugli.
Pinin per la prima volta in vita sua pianse: mentre correva via la tristezza di prima lo prese ancora più forte e, agitato da emozioni di rabbia e sconforto, si lasciò andare al suo primo pianto.
Passò un’oretta. Si fermò su un sasso, in una zona poco battuta giusto al limitare del bosco dei Rebecc. La sera era alta, lo scuro e la quiete si posarono come leggero mantello su tutte le cose. Nell’animo la bufera agitata cominciava a quietarsi, a specchio dell’atmosfera d’intorno. Dei grossi respiri che si fondevano col fruscio delle piante l’aiutavano a placarsi e a tornare in sé. Era ancora solo, era sempre Pinin, ma ora gli andava bene; era fiero di essere lui, Pinin. Sgagnò un pezzo della schifosa polenta e il resto lo buttò via.
«Balliamo, diavolone scorreggione? Ih ih ih…». Avvertì un sussurro. Cos’era? Prima della comprensione un’inquietudine sinistra. Scese il torpore, salì l’allarme. Così serpeggiò l’eco del sussurro, gli alberi si fermarono, il vento zitto smise di accarezzare le cose e i fiori smisero di profumare. Altre volte, l’abbiamo detto, gli era parso di sentire delle vocine mentre vagabondava la sera, ma mai così nitidamente. La voce rauca l’avvertiva interiormente e gli riverberava nelle membra come se non arrivasse da fuori ma da dentro.
Lì a fianco una viuzza si apriva tra alcune fronde immobili e tetre che disegnavano un varco tra il fitto muro di piante. Pinin era passato di lì qualche volta, ma non ricordava quel passaggio che sembrava essersi materializzato in quel momento. Era sì inquieto e un particolare timore l’aveva preso, ma com’è e come non è era preso anche da un’ardente curiosità. In quell’atmosfera zitta in cui il silenzio attorno era vero silenzio senza sfondo, la natura non lo respingeva, ma anzi lo invitava.
Oh, quanti in questo frangente dovrebbero scappare storditi dal terrore, impauriti di scoprire i segreti. Quasi tutti. Ma non Pinin. Rifattosi l’animo per l’avventura prese la via nel buio pesto: schiacciava le foglie che però stranamente non si volevano accartocciare e rimanevano ferme il più possibile per non farsi sentire; il fango lo faceva scivolare, ma anche lui – il fango – poi si premurava di attutirne le cadute e di non fare cicic e ciciac; anche i ramoscelli quando Pinin provava ad afferrarli per tenersi in equilibrio si spostavano, non fosse mai che li spezzasse con una mano e facessero un sonoro crac! Il sentiero finì. Si apriva su una radura.
Alta in cielo campeggiava verdognola la luna, più grossa del solito. Guardava in giù e pareva che fosse in riunione con qualcuno. Un vociare concitato ma etereo roteava per la radura portato da un nuovo vento caldo e le parole, complicate da intendere, arrivavano all’orecchio di Pinin in pezzi disordinati, alla maniera di un’eco che rimbomba tra le pareti. Poco più avanti, sotto i rami abbondanti di un olmo enorme crepitava un fuocherello verde e violaceo, che sfumava dei suoi colori anche una parte di cielo. Attorno sedevano tre figuri che discutevano animatamente. Difficile a dirsi, ma dalle sagome lasciavano intendere d’essere una donna e due uomini. Uno dei due uomini aveva su un cappellone tutto scalcagnato che doveva salir dritto ma pendeva di qua e di là a zig-zag. Continuava a muovere la testa a scatti, sputacchiando per terra e inveendo contro qualcuno. L’altro aveva delle lunghe zampe: cominciavano muscolose e dritte, ma scendendo si affusolavano in uno zoccolo caprino che terminava con un affilato tacco a spillo. Aveva una codona biforcuta con cui pareva pettinarsi un ciuffo corvino e lucido, e se ne stava sulle sue, piuttosto in disparte. La donna invece continuava a saltellare in giro e ridacchiava. Aveva i capelli radi e umidi che attorcigliava compulsivamente attorno a un dito, una lunga pelliccia ispida su tutto il corpo che la faceva quasi assomigliare a un istrice e un vistoso rossetto un po’ sbavato. Erano un mago, un diavolo e una strega. Sarà stata mezzanotte, Pinin stette nascosto e osservò.
«E quindi, se mi vuoi dare un attimo retta, come stanno andando le cose? Ma stai ferma, stupida d’una strega! Cerchiamo d’essere seri per l’amor dell’Averno!» disse il diavolo alzando gli occhi al cielo. La strega infatti seguitava nella sua danza squinternata e gli rideva in faccia senza dargli retta. In mano teneva una pipa a forma di lumaca da cui aspirava lunghe boccate di fumo che andava poi a sbanfare in faccia ai suoi compagni. L’altro individuo, il mago, era quanto di più sgangherato si possa immaginare: era circondato da una decina di bottiglie di intrugli alcolici, ne tirava su una, faceva un bel sorso e l’appoggiava. Dopo di che bestemmiava, sputava per terra e poi si metteva a fare la conta per vedere quale fosse la prossima bottiglia da cui tracannare.
«Ragazzi, per favore, cercate di capire. Quando vado ai sabba con tutti gli altri maligni mi prendono tutti in giro. Quelli arrivano tutti tracotanti e dicono: “Noi qua nel Varesotto abbiamo mutilato teste!”, “Noi qua nella Val Chiavenna abbiam fatto a brandelli interi paesi”. Persino dalla Val d’Intelvi e da Monza: “Per conto nostro abbiamo avvelenano i nuovi nati”, oppure “Noi altri invece abbiamo ucciso i figli del re!”. Poi arriva il mio turno e noi non abbiam fatto niente! Al massimo tu, Mago, hai defecato per sbaglio per strada o tu, Strega, stavi facendo delle avances alla locandiera e ti sei presa delle borsate su quella testaccia vuota. E quelli ridono, ridono…». Era completamente sconfortato.
«Allora, siete sicuri? Niente neanche questa settimana?». «No! No! No! Io non ho fatto niente! Niente! Non ho tempo! Non mi va! Sono un mago io! Taci diavolo d’un diavolo. Tu e la tua coda storta! Fatti i cazzi tuoi, damerino! Puah!» disse il Mago. Intervenne la strega: «Sta’ buono, diavolone! Sapessi, sapessi ih ih ih… Io qualcosinaaa l’ho fattaaa! E togliti quell’aria ingessata! Fai una bella boccata dalla pipa, su su!». «No! Lo sai che non mi piace, e poi mi fa venire mal di testa quella roba. Dimmi, dimmi, ti prego, cos’hai combinato?». «Uhm, uhm, diavolone d’un pistolone ih ih. Ci sei poi uscito con quell’altro diavolotto, eh, passerotto?!». «Non sono affari tuoi! Dimmi solo dei tuoi malaffari» le rispose imbarazzato. «Va bene, va bene. Ma insomma, l’altra sera passavo dal paese e volevo andare a vedere la Rosina, la sciura del mugnaio. Mi sono acquattata sotto la sua finestrina e le ho mandato un bacino. Di tutta risposta quella si affaccia e mi fa: “Ta set una schifusa! Mi ta vöri no! Ta me fe schivi”. Beh, io ci sono rimasta malissimo e allora mi son detta: “cià che le avveleno la figlia”. Ho fatto su una pozione e mi sono intrufolata nella camera. E pensa te, per tutti i pistoloni dei diavoloni, nel letto insieme alla figlia della Rosina c’era la figlia del conte Durini! Stavan lì ad amoreggiare, a fare mugugni e a darsi bacini e bacetti. Io, beh, mi son fatta prendere dall’invidia e zac! Le ho avvelenate tutt’e due». «Oh, beh, benissimo! Benissimo! Evviva! E che pozione mefistofelica hai architettato, eh? Diventeranno decrepite nel giro di qualche giorno? Moriranno nel sonno? Diventeranno cannibali? Ah ah! Dimmi Strega, dimmi». «Ma no, ma no! Cosa vai a pensare sciagurato d’uno sciagurato! Gli ho fatto venire il cagòt, come lo chiamano loro, e non gli passerà prima di due mesi! Ih ih ih!». «Come?! La dissenteria?! Ma mica si muore di quella!», era affranto e deluso come non mai. «Niente, mi devo rassegnare a un altro sabba di prese per i fondelli». «Per il culo! Si dice “prese per il culo”! Sciocchino d’uno sciocchino» lo scimmiottò la strega.
«Ma guarda tu, guarda tu con chi dovevo capitare. M’avessero messo con la Bissaga della Val d’Intelvi, quella sì che è cattiva. E invece no. Son qui in ‘sta brughiera con te che fai venire addirittura, pensa un po’, i mal di pancia! Che spavento! E quell’altro che fa la conta tra una bottiglia d’amaro e il bottiglione di rosso e neanche si ricorda più come si chiama». Subito gli fece eco il mago che tra un sorso e l’altro sentiva qualche parola: «San Giorgio! Sono San Giorgio io! Ho sconfitto un drago io! Mai sentito?! Eh?! Ah! Porcello! Sei un povero porcello! Non capisci niente! San Giorgio! Non conosce San Giorgio! Scemo!». «Va bene, quello che è. Lasciamo perdere. Strega, voglio almeno sperare che la dissenteria non gli passi in fretta, eh! Due mesi filati! C’è una cura?». «Sì! Due mesi filati di caccona nei bragoni! Ih ih ih! E la cura sì che c’è, ma mica lo sanno, pollastro d’un pollastro! C’è qui sotto l’albero una giara con dell’acqua santa che ho rubato al prevosto di Chiaravalle. Quella le farebbe guarire… se la bevessero. Ih ih ih!». «Va bene, e sia. Ritiriamoci ora, che ho un appuntamento con Malacoda» e nel mentre si mise del rossetto. «Arrivederci» rispose la strega. E subito dopo: «Ah! Diavolone!». «Dimmi». «Sai che a Chiaravalle hanno una filastrocca sull’acqua santa del prevost! Senti qua: ul prevost de Chiaraval quand el caga ‘l se sbrofa i ball. Ih ih ih! Ih ih ih!». «Perché a me? Perché?».
In un baleno sparirono, il diavolo aperse una porta nell’albero e si defilò, la strega fece una giravolta e scomparve dentro un buco nel terreno. Il mago rimase lì solo. «Dove sono andati adesso?! Maledetti figliacci d’un lombrico!». Stava per infilarsi in una damigiana quando alzò lo sguardo proprio nella direzione di Pinin che era rimasto là nascosto per tutto il tempo, inquieto e assorto. Gli sguardi s’incrociarono: «Drago! Ancora qui sei?! Non ti avevo fatto fuori, sciagura del mondo? Io, San Giorgio, io ti ricondurrò a giustizia!». Fece per mettersi a correre, ma al primo passo scivolò su uno dei suoi fiaschi e pestò il grugno. La rabbia e la botta tanto bastarono a fargli dimenticare il suo proclamo in veste di santo e così, puf, bestemmiando sparì nella damigiana. Pinin tirò il fiato.
Quei tre avevano parlato in un modo che non gli era stato tutto comprensibile, ma bene o male gli pareva d’aver capito le cose importanti: «U mia capì tüt quel ch’an dì, ma sun sigür che quela dona l’eva ‘na stria e che suta la pianta gh’è na buteja d’acqua che l’a de vess cum’è ‘na medisina per la tusa da Rusina e quela dal Conte». Così, con fare circospetto, si avvicinò al fuocherello che s’era intanto spento e non cacciava nemmeno più fumo. Con solo la luce della luna, che era tornata bianca, e quella delle stelle frugò tra le radici dell’olmo e dissotterrò una giara piena d’acqua.
Per Pinin quel sabba era stato ben assurdo, ma era stata una delle pochissime volte in cui delle persone non gli avevano restituito quell’impressione fastidiosa di falsità. Come dicevamo prima, quanti sarebbero rimasti paralizzati nel terrore, quanti sarebbero morti all’occhiata del mago o sconvolti al parlar della strega. Quasi tutti. Ma non Pinin, che con gli spiriti e le magie andava d’amore e d’accordo.
Sul far del mattino si presentò allora, beato beato, di fronte alla porta del mugnaio. «Buondì, vuraria vedè la vostra tusa». «Ma cuss’è ca ta vörat Pinin, mena i toll che la mia tusa la sta gnanca ben. Sciò!». «L’è propri par quel ca sun chi. Mi go la soluzion! La ga de bef quel’acqua che». Peppino, detto Pepp “de la cassina”, era così disperato per la figlia – la quale da una settimana non poteva uscire dal bagno – che acconsentì a quella che riteneva una follia. Rimase di stucco quando la figlia, appena fatto un sorso da quella strana giara che aveva portato quel martul di Pinin, si riebbe all’istante e cominciò a baciare le mani sue e quelle del suo salvatore: «Grazie Pinin, grazie, ta set un angel. Na pudevi pü da quela spüsa de merda! Grazie!». Festante Peppino andò a prendere 10 sacchi di farina, 20 ciabatte, 30 rosette e provò a convincere Pinin a prendere tutto. «No, no, grazie Pepp, ma mi stu ben inscì, go mia besogn de tüta chela roba chi. M’acuntenti d’un tuchel de pan». Così prese una pagnotta sola, si girò e se ne andò. Pepp e Rusina lo guardarono andarsene, senza capire. Ma questo non era una novità.
Adesso c’era da andare dal Conte. Lieto come non mai e grato di poter fare del bene, Pinin sentiva in sé la forza della riscossa e la natura tornava di rimando a salutarlo e a renderlo felice. Per tutta la strada dal paese fino al castello aspirò a pieni polmoni l’aria d’autunno coi suoi profumi, mentre si beava del pizzicore dovuto al freddo e della fatica che lo accompagnava per via della notte insonne. Ancora avvertiva nell’atmosfera qualche sussurro, una certa inquietudine lo veniva a solleticare, ma subito si tramutava in gioia perché Pinin aveva a quel punto capito che anche quelle cose facevano parte della sua natura.
Poco dopo il mezzogiorno si presentò sotto le mura: «La ma scüsa!». «Chi è?» rispose scontrosamente una guardia. «Mi sun Pinin e sun vignü scià per dac la medisina alla tusa dal Conte». Quello, frastornato, non capì e pensò che lo stesse prendendo in giro: «Desfescias, bigul! Gh’em mia temp chi par i martul che disan panzan». «Ma va che disi da bon. Vuraria parlà cunt ul sciur Durini, cun Sua Maestà». «Mah! ‘Specia». La guardia rientrò e poco dopo comparve all’uscio del pianterreno e fece entrare l’attendente.
Anche il Conte, così come il mugnaio, non sapeva più che pesci pigliare e avrebbe provato di tutto pur di far star bene la Principessina che ormai da giorni non poteva allontanarsi che di qualche metro dal bagno per via di una fortissima dissenteria. Dentro, il castello era magnificente, luminoso e come dorato anche in ottobre, la servitù schierata in pose impettite e sottomesse. Il Conte, non diverso da tutti gli altri, lo squadrava dall’alto in basso, senza riporre in lui una vera fiducia. Alle spalle il volto triste della Principessa era bianco e stravolto.
«Alura, cuss’è che ta gh’et par me, per la mia tusa». «Varda, sun vignü a savè che la g’a ul cagòt. Ecu, mi gu che la medisina. Basta fac bef un zichinin dala giara che la sarà apost». Stesso copione che con la figlia del mugnaio: la ragazza fece un sorso e immediatamente si riebbe, si tirò in piedi e cominciò a gridare per la gioia elargendo baci a tutti e arraffando un pezzo d’arista qui, una coscia di pollo là e una fetta di pane imburrato con un bicchierone di vino. Il Conte esterrefatto fece portare un forziere colmo di monete per il salvatore: «Ecco, ciapa, ciapa! L’è tüta roba tua adess. Benedett, te set un fiö benedett! Varda, ta disi n’oltra roba. Te gh’è vöja de maridà la mia tusa? L’è tüta strana, la va sempar gio in paess (a fa cuss’è pö?) e la vör mia sentì da spusass. La ta piass?». Pinin però sapeva che il cuore della giovane risiedeva altrove – ricordava le parole della strega – e poi, per la verità, quella proposta fatta così, senza consultare la ragazza gli aveva fatto accapponare la pelle. Si ritrovò di nuovo a rifiutare un’offerta, stavolta ben più convinto: «No, no. Mi stu ben inscì» disse anche al conte Durini. «Sun cuntent che la tusa la sta ben e pö la duaria fa quel ca vör lè. Per i danè, ma piasaria de dagai tücc a la servitù». «E va ben» opinò quello. E poi aggiunse bisbigliando: «Martul».
Col sorriso sotto i baffi Pinin se ne andò: un paio di monete in tasca, la giara adesso vuota e ancora un po’ di pane. La voce delle sue gesta miracolose si era sparsa per il paese e in quelli limitrofi e ora nel passare la gente lo guardava e lo salutava. Ma lui non gli dava retta: «Mi sun Pinin “ul martul”, vi olter siit catiff e a mi ma ‘nteressa no».
Nel tardo pomeriggio era fuori la casupola di Pedar, stanco stanco. Voleva entrare a dormire quando gli sovvenne di Sdraéla. Gli venne in mente di fargli ancora visita, per congedarsi da lui in un altro modo. Non gli piaceva averlo maledetto la sera prima e voleva salutarlo senza livore. Il vento, le stelle che arrivavano e la luna erano al loro posto. La sera fresca calzava la sua veste con serenità, accompagnata dal gracchiare di qualche cornacchia. Fischiettando si approssimò al casolare, la luce calda che veniva da dentro gli certificò che marito e moglie erano a casa. Bussò.
Ad aprire c’era proprio il fratello. Angelina spalancò gli occhi bisbigliando: «Oh signur, amò l’è chi stu gabian». «Ah Pinin. Anca mo chi ta set? Se ghè? Adess sevum drè a mangià dü rop… poca, pochissima roba, eh!» gli fece Sdraéla mentre dietro di lui sbucava un bell’arrosto succulento. Pinin sorrise in modo buono e sincero, anche se lievemente amaro: «Nagot, nagot, sta quiett. M’è mia piasü in ier cum’è che t’ho salüdà e vulevi dumandat scüsa, l’è dumà par quell. Ah! Ciapa anca sta muneda. L’è per la pulenta che te me dà l’oltra sira. Arrivederci Sdraéla, salve sciura Angelina».
Sull’uscio Pinin stava per girarsi e andarsene senza che, per la terza volta, quelli a cui dava le spalle – così infatti anche il mugnaio Pepp e il Conte – lo comprendessero. Non lo comprese infatti Sdraéla, che però parlò lo stesso. Ed era la cupidigia a parlare, stupefatta di quel soldo d’oro luccicante che il fratello gli aveva porto senza alcuna malizia: «Specia ‘n atim Pinin, caru fredel! In dü è che t’e truà gli sghei? Tant par savè eh, vöri mia ciapà i tò» sorrise mellifluo. Ne nacque il lungo racconto della serata precedente, con marito e moglie che si alternavano tra l’incredulo, l’arrabbiato e il curioso. Erano d’altra parte piuttosto superstiziosi e la vicenda li intrigava. Più di tutto era intrigato il loro appetito per le monete. Pinin alla fine concluse il racconto raccomandando: «Ma racumandi, eh! Stac atent a fass mia vedè. Pö, cume sevi drè a dì, i eran là da par lur ier sira. Magari incö en mia là. Se ta vörat vedei, pröva tra ‘na setimana. E stac atent, par amur dal ciel». E così se ne andò. Era buio pesto. Tutto era una serenità. Non vedeva l’ora di tornare a fare le pirolette con Pedar e far ridere i bambini.
Angelina era un po’ preoccupata e un po’ voleva far desistere Sdraéla dall’addentrarsi nel bosco a quell’ora. Un po’, appunto, ma non abbastanza, giacché a lei stessa tirava estremamente gola la possibilità di trovare una qualche cornucopia ricca d’oro. Le raccomandazioni di Pinin erano state prese come le fandonie di uno sciocco e così tutta la sua storia. Quel che s’aspettavano era di trovare abbandonata tra le radici di un olmo qualche altra anfora piena ancora di monete dorate che quel martulott di Pinin aveva dimenticato di raccogliere.
Sdraéla uscì di casa. Lui non l’ascoltava la sera e non si accorse che il mondo era ridiventato muto, come e più che la notte precedente. Il vento non stormiva, immobile e teso, i fiori non profumavano e il silenzio innaturale dominava. Passando Sdraéla attraverso la via scura, le foglie continuavano ad accartocciarsi maligne e svegliavano tutti gli animaletti, che fuggivano via. Il fango s’era fatto limaccioso e come su delle sabbie mobili continuava a far inciampare il goffo uomo che imprecava e ansimava ad ogni caduta. I ramoscelli dalle piante si allungavano come braccia traditrici verso di lui per farsi afferrare e spezzarsi: cric, crac, ad ogni piè sospinto. Infine, trafelato e in preda ad un freddo quasi doloroso che lo faceva tremare, eccolo uscire sulla radura. Non v’era fuoco, né luna e in lontananza si stagliavano tre figuri.
Parevano degli amalgami fatti di pece e budella e Sdraéla ammutolì, paralizzato dall’orrore. Uno arrancava lento e silenzioso muovendosi in tondo, coperto da una tunica nera. Aveva gli occhi bianchi e incavati e perdeva una bava densa che bruciava l’erba dove passava. Era Malattia. Il secondo aveva un incedere elegante e sinuoso e mandava dalle fauci una nebbia nauseabonda che permeava l’aria. Stava avvolto in un abito di velluto rosso, dalle cui maniche fuoriuscivano degli artigli simili a rami grigi. Aveva scoperto il torso, dove una colonia di ragni orrendi brulicava masticando pezzi di carne. Era Gola. Il terzo aveva calcato sul capo un teschio animale levigato che sembrava fatto d’avorio. Aveva gli arti sottilissimi e divorati da una piaga e piroettava in giro con uno sguardo vuoto e famelico. Era Bugia. Parlavano una lingua di morte e le voci non si udivano, ma rimbombavano ugualmente tra le tempie madide di gelido sudore di Sdraéla. Il vociare raccapricciante si confondeva, come un organo che inneggi note di disperazione.
«Le figlie del mugnaio e del Conte sono guarite. La giara è scomparsa. Qualcuno ha spiato, quindi, qualcuno ha voluto guastare i nostri segreti». «A quanto pare…». Venne un silenzio assordante. «C’è qualcosa che non va. Ci sono degli occhi d’agnello che ci fissano. Piccola oscenità, vieni a nutrire la tua e la nostra ingordigia!». Il longilineo dei tre si sollevò dalla posa china che aveva assunto, alzò lo sguardo e fissò con gli occhi vuoti quelli terrificati di Sdraéla. Tutti allora si voltarono verso di lui. «Ssst! Ti mangio!».
Oh, quanti in questo frangente sarebbero rimasti paralizzati dal terrore feroce, quante menti collassate orrendamente per il raccapriccio di un orrore così profondo. Così Sdraéla, che venne mangiato.
Quella sera Pinin, nel suo letto di paglia, si addormentava sereno.
di Francesco Camagna
illustrazione di Marta di Donna
Illustrazioni di Marta Di Donna